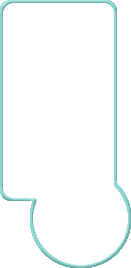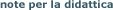
Ciprinidi
La natura nell'acqua
| I pesci
del parco del Taro | Ciprinidi
CIPRINIDI
Barbo
comune
Cavedano
Barbo canino
Gobione
Vairone
Alborella
Carpa
Carassio
Lasca
Savetta
Barbo comune
Barbus plebejus
Caratteristiche: linea laterale con 58-77 squame;
pinna dorsale con 4 raggi indivisi e 8/9 divisi; pinna
anale con 3 raggi indivisi e 5 divisi; denti faringei
triseriati. Lunghezza massima fino a 60 cm; peso fino
a 4 kg.
Le caratteristiche diagnostiche che riportiamo sono quelle
classiche riportate nei testi di ittiologia; va segnalato
doverosamente che la tassonomia di questa specie e di
tutto il genere Barbus sono attualmente in fase
di revisione; questo fatto potrebbe portare a delle sostanziali
variazioni di quanto precedentemente indicato.
 Descrizione:
si riconosce facilmente dalla caratteristica bocca infera
munita di 4 bargigli, di cui la coppia posteriore è nettamente
più lunga di quella anteriore; il corpo è affusolato,
con la parte ventrale quasi rettilinea e quella dorsale
decisamente incurvata; è ricoperto da squame piuttosto
grandi, anche se più piccole di quelle del barbo canino. Descrizione:
si riconosce facilmente dalla caratteristica bocca infera
munita di 4 bargigli, di cui la coppia posteriore è nettamente
più lunga di quella anteriore; il corpo è affusolato,
con la parte ventrale quasi rettilinea e quella dorsale
decisamente incurvata; è ricoperto da squame piuttosto
grandi, anche se più piccole di quelle del barbo canino.
Il capo è alquanto allungato; gli occhi sono piccoli,
scuri, rivolti leggermente verso il basso. Il dorso è
bruno scuro o bruno-verdastro, i fianchi sono in genere
dello stesso colore con riflessi dorati, il ventre biancastro,
anche se si notano sfumature cromatiche a seconda dell'ambiente
in cui vive.
Le pinne sono di grigiastre o brune, ma durante il periodo
delle fregola possono assumere sfumature rosse o arancio.
Sono presenti numerose piccole macchie brune su tutto
il corpo ed in particolare sulla pinna dorsale e su quella
anale.
Biologia: predilige i corsi d’acqua di fondovalle
o dell'alta pianura, con acque correnti, limpide e fresche,
a fondo ghiaioso, sassoso o sabbioso, preferibilmente
con portate idriche medio-alte. E’ un ottimo nuotatore,
ed è facile notarlo in corrente od in prossimità di massi
o piloni sommersi dove l'acqua crea dei vortici. È una
specie gregaria, che forma branchi di numerosi individui.
È un pesce di fondo che fruga, soprattutto di notte,
tra i ciottoli alla ricerca di cibo, aiutato dai barbigli
che hanno anche una funzione tattile. Le sue prede sono
costituite da vermi, molluschi, larve di insetti, uova
ed avannotti di altri pesci e talvolta da detriti vegetali.
Trascorre l'inverno in uno stato di semi-letargo, di
solito protetto in buche profonde.
La riproduzione avviene da maggio a luglio a seconda
delle zone, su fondali ghiaiosi o sabbiosi; la femmina
depone fino a 20 mila uova di piccolo diametro, leggermente
adesive, che possono venire fecondate anche da più maschi.
Subito prima del periodo riproduttivo è in grado di compiere
notevoli spostamenti (a volte anche per decine di Km)
alla ricerca dei luoghi adatti alla riproduzione.
Distribuzione: nelle acque del Taro all’interno
del parco il barbo comune è una specie diffusa ed abbondante.
Il Barbus plebejus, recentemente
elevato al rango di specie differenziandolo dal barbo
transalpino Barbus barbus, è una specie diffusa
in buona parte d'Italia, isole escluse, ed in Dalmazia.
Torna all'inizio
Cavedano
Leuciscus cephalus
Caratteristiche: 41- 40 squame lungo la linea
laterale; pinna dorsale con 3 raggi indivisi seguiti da
7/9 divisi; pinna anale anch'essa con 3 raggi indivisi
seguiti da 7/9 divisi; denti faringei su due file; lunghezza
massima 60 cm; peso fino a 6 Kg.
 Descrizione:
è un pesce dal corpo massiccio, quasi cilindrico, allungato;
la bocca è piuttosto grande, obliqua, rivolta verso l'alto
e dotata di labbra robuste. Le squame sono grandi, di
colore brillante, provviste di una fine punteggiatura
nera, quasi unita a formare una specie di reticolo; il
margine è sempre più scuro. La linea laterale appare molto
evidente. Descrizione:
è un pesce dal corpo massiccio, quasi cilindrico, allungato;
la bocca è piuttosto grande, obliqua, rivolta verso l'alto
e dotata di labbra robuste. Le squame sono grandi, di
colore brillante, provviste di una fine punteggiatura
nera, quasi unita a formare una specie di reticolo; il
margine è sempre più scuro. La linea laterale appare molto
evidente.
La colorazione del dorso è variabile in una ampia gamma
di grigi fino ad un colore brunastro; i fianchi, anch'essi
di colorazione assai variabile, presentano riflessi argentei
o dorati. Gli occhi sono grandi e di colore giallo dorato.
Biologia: è un pesce che popola prevalentemente
le acque correnti e limpide, spingendosi a volte in profondità
nella zona a trote; al tempo stesso si può rinvenire anche
in acque tipicamente ciprinicole o addirittura salmastre.
Gli individui giovani mostrano tendenze gregarie formando
branchi composti anche da un centinaio di individui; i
soggetti adulti sembrano manifestare tendenze più solitarie.
Si tratta di un pesce praticamente onnivoro, con una dieta
che comprende larve acquatiche e insetti alati, piante
acquatiche, uova, avannotti; a volte pratica anche l'ittiofagia.
È specie ad alto potenziale riproduttivo, la femmina
può deporre fino a 200 mila uova, nel periodo compreso
fra aprile e luglio a seconda delle località e della temperatura
dell'acqua.
La deposizione delle uova avviene nelle vicinanze delle
rive su ghiaia fine, sabbia, pietrisco ma a volte anche
su vegetazione acquatica. La schiusa avviene, a seconda
della temperatura dell'acqua, in 3/7 giorni, l'accrescimento
è piuttosto lento e la maturità sessuale non viene raggiunta
prima del quarto anno di vita.
Le popolazioni di cavedano sono piuttosto resistenti
all’inquinamento e sembrano attualmente in una fase di
espansione demografica, probabilmente favorite in questo
da un deterioramento generale della qualità delle acque
dei fiumi italiani e dalla manomissione diffusa degli
alvei, dimostrandosi sotto questo aspetto una specie estremamente
opportunista.
Distribuzione: nel settore di Taro ricedente nel
parco il cavedano risulta una specie molto comune presente
con popolazioni molto ricche di individui.
Questa specie è inoltre presente in
tutta Europa con varie sottospecie, anche se recentemente
la validità tassonomica di molte di esse stata messa
in discussione.
Torna all'inizio
Barbo canino
Barbus meridionalis
Caratteristiche: 48-55 squame lungo la linea laterale;
pinna dorsale con 3 raggi indivisi e 7/9 divisi; pinna
anale con 2/3 raggi indivisi e 5/6 indivisi; la lunghezza
massima è di 30 cm; il peso fino a 300 grammi.
 Descrizione:
è simile nella sua forma generale al barbo comune, ma
le dimensioni sono più contenute. Si differenzia soprattutto
per la numerose macchie brune, assai più grandi di quelle
notate nel barbo comune, disposte sul dorso e sui fianchi.
Tutte le pinne presentano una macchiettatura nerastra.
Durante il periodo della fregola le pinne pettorali, ventrali,
anale ed anche i bargigli possono assumere una colorazione
rossastra od aranciata. Descrizione:
è simile nella sua forma generale al barbo comune, ma
le dimensioni sono più contenute. Si differenzia soprattutto
per la numerose macchie brune, assai più grandi di quelle
notate nel barbo comune, disposte sul dorso e sui fianchi.
Tutte le pinne presentano una macchiettatura nerastra.
Durante il periodo della fregola le pinne pettorali, ventrali,
anale ed anche i bargigli possono assumere una colorazione
rossastra od aranciata.
Biologia: predilige le acque correnti e fresche
e si spinge a monte, nella zona delle trote, con più facilità
rispetto al barbo comune. Le linee generali della biologia
di queste due specie sono sovrapponibili, anche se effettivamente
le conoscenze specifiche sul barbo canino sono piuttosto
contenute. L'alimentazione è legata strettamente alle
sue abitudini di pesce di fondo, dove rinviene vermi,
larve di insetti, molluschi, uova ed avannotti. La riproduzione
avviene fra maggio e giugno, la deposizione delle uova
è legata a substrati di tipo ghiaioso o sabbioso. L'accrescimento
di questa specie è piuttosto lento.
È una specie in fase di contrazione demografica, troppo
spesso non adeguatamente protetta; sarebbe auspicabile
il divieto di pesca, almeno nelle regioni dell'Italia
nord-orientale dove le popolazioni sono in genere assai
ridotte.
Distribuzione: il barbo canino è piuttosto raro
nelle acque del parco, dove è presente con un numero limitato
di individui principalmente nel tratto iniziale compreso
fra Fornovo e Giarola.
Si tratta di una specie tipica dell'Europa
meridionale, dove si rinviene nel bacino meridionale del
Rodano ed in diversi dei fiumi che sfociano nel Mediterraneo.
Nel resto dell’ Italia la sua distribuzione è poco conosciuta,
ma è segnalato in quasi tutta la zona centro-settentrionale.
Torna all'inizio
Gobione
Gobio gobio
Caratteristiche: linea laterale con 36-44 squame;
pinna dorsale con 5/7 raggi divisi; pinna anale con 6/8
raggi divisi; 2 barbigli ai margini della bocca.
Lunghezza massima fino a 20 cm; peso fino 150 gr.
 Descrizione:
il corpo si presenta allungato, anteriormente subcilindrico
con la tendenza a comprimersi lateralmente nella regione
caudale. Descrizione:
il corpo si presenta allungato, anteriormente subcilindrico
con la tendenza a comprimersi lateralmente nella regione
caudale.
Il capo è massiccio, la bocca, dotata di labbra carnose,
è provvista di due barbigli inseriti a livello della mascella
superiore.
Il corpo è ricoperto da squame piuttosto grosse, ben
impiantate con una linea laterale ben evidente.
L'origine delle pinne ventrali è arretrata rispetto all'origine
della dorsale.
La colorazione è variabile; in genere il dorso è brunastro,
i fianchi ed il ventre sono marroni o giallastri; una
serie di grosse macchie brune è presente nella parte alta
dei fianchi a formare una specie di banda subito sopra
il profilo della linea laterale; le pinne presentano una
fitta macchiettatura bruno-nerastra.
Biologia: è un pesce gregario, vive in gruppi
numerosi sia in acque veloci, dove può spingersi sino
alla zona del temolo, che in acque potamali purché a fondo
sabbioso e non eccessivamente inquinate, dato che questa
specie risulta esigente in fatto di ossigeno disciolto;
è presente anche in acque lacustri.
L'alimentazione è essenzialmente a base animale: larve
d’insetti acquatici, vermi, molluschi, crostacei, talvolta
piccoli pesci sono le sue prede principali. Nella ricerca
del cibo si serve dei barbigli che svolgono una funzione
sensoriale.
Vive abitualmente in profondità, anche se durante il
periodo caldo tende a portarsi verso la superficie o in
acque poco profonde.
La riproduzione avviene da maggio a giugno, le uova vengono
deposte sul fondo e schiudono in due o tre settimane;
secondo alcuni autori (Tortonese, 1970) ogni femmina depone
da 1000 a 3000 uova, secondo altri (Chaumeton, 1985) soltanto
poche centinaia una sola volta nella vita.
L'accrescimento è lento ed al primo anno di età raggiunge
a malapena i 5 cm.
Distribuzione: nelle acque del Taro il gobione
è presente con una certa regolarità, ma con un numero
limitato di individui, nel tratto iniziale di competenza
del Parco compreso all’incirca fra Fornovo e Giarola.
In Italia la specie è presente essenzialmente
nelle acque del bacino padano; è presente inoltre in quasi
tutto il resto d'Europa, Asia settentrionale e centrale
sino alla Mongolia.
Torna all'inizio
Vairone
Leuciscus souffia
Caratteristiche: pinna dorsale con 10 raggi, pinna
anale con 10-13 raggi divisi, pinna ventrale con 10 raggi.
Presenza di denti faringei. Lunghezza massima 25 cm.
 Descrizione:
il corpo è fusiforme, lateralmente poco compresso; il
dorso è di color nero-grigio con riflessi blu metallico,
i lati sono argentei, il ventre è bianco argenteo. Le
pinne hanno una colorazione arancio nella parte basale. Descrizione:
il corpo è fusiforme, lateralmente poco compresso; il
dorso è di color nero-grigio con riflessi blu metallico,
i lati sono argentei, il ventre è bianco argenteo. Le
pinne hanno una colorazione arancio nella parte basale.
La bocca è in posizione ventrale. La linea laterale è
giallo-rossastra.
Biologia: vive prevalentemente
in prossimità del fondo, dove trova anche il nutrimento
costituito da plancton, vermi, piccoli animali bentonici
e talvolta anche da elementi vegetali.
La riproduzione avviene nel periodo tardo primaverile;
gli individui raggiungono la maturità sessuale a 2 o 3
anni; i maschi presentano, in questo periodo, piccoli
tubercoli nuziali sulla testa e sulle pinne pettorali.
È una specie
amante di acque limpide, ricche di ossigeno e dotate di
una discreta velocità di corrente; Il vairone è una specie
di abitudini gregarie e forma spesso branchi di numerosi
individui.
Colonizza principalmente il medio corso dei fiumi sovrapponendosi
in parte alla zona terminale di distribuzione dei salmonidi
ed occupando, in genere, la stessa fascia longitudinale
in cui sono presenti anche il barbo canino e la sanguinerola.
Il vairone è una specie di abitudini gregarie e forma
spesso branchi di numerosi individui.
Colonizza principalmente il medio corso dei fiumi sovrapponendosi
in parte alla zona terminale di distribuzione dei salmonidi
ed occupando, in genere, la stessa fascia longitudinale
in cui sono presenti anche il barbo canino e la sanguinerola.
L'accrescimento lineare non risulta molto veloce: alla
fine del primo anno di vita i giovani vaironi misurano
circa 6-7 cm, 10-12 cm alla fine del secondo e circa 13-14
cm verso la fine del terzo anno; solo pochi individui
in genere raggiungono dimensioni maggiori.
Il vairone è una specie che ha subito una forte contrazione
del proprio areale di distribuzione nel corso di questi
ultimi decenni, principalmente a causa della manomissione
idraulica ed al degrado di molti di quei corsi d'acqua
pedemontani che costituivano il suo habitat preferenziale.
Distribuzione: il vairone è presente con regolarità
in tutto il tratto di Taro compreso nel parco; da un punto
di vista quantitativo la specie risulta leggermente più
abbondante nel tratto iniziale compreso all’incirca fra
Fornovo e Giarola.
Il vairone è presente in quasi tutta
l’Italia centro-settentrionale.
Torna all'inizio
Alborella
Alburnus alburnus
alborella
Caratteristiche: linea laterale con 42 - 51 squame;
pinna dorsale con 3 raggi indivisi seguiti da 7/8 divisi;
pinna anale con 13/17 raggi divisi; lunghezza massima
fino a 20 cm, peso fino a 50 gr.
 Descrizione:
è un piccolo pesce dalla forma assai slanciata; la bocca
è abbastanza piccola, nettamente obliqua; la mascella
inferiore è leggermente prominente. Descrizione:
è un piccolo pesce dalla forma assai slanciata; la bocca
è abbastanza piccola, nettamente obliqua; la mascella
inferiore è leggermente prominente.
La pinna caudale è forcuta, appuntita agli apici; la
pinna anale prende origine all'altezza degli ultimi raggi
della dorsale.
Il colore del dorso è bruno-verdastro, i fianchi ed il
ventre sono argento brillante; è presente inoltre una
banda longitudinale di colore grigio-verde che va dal
margine posteriore dell'opercolo al peduncolo caudale.
Biologia: è una specie dalle spiccate abitudini
gregarie, vive di regola in branchi anche molto numerosi
sia nelle acque correnti che in quelle lacustri.
Predilige acque limpide non troppo fredde e si rinviene
sia negli ultimi tratti del rhitron che nel potamon, dove
però evita le acque troppo torbide, con vegetazione eccessivamente
fitta o con bassi tenori di ossigeno.
Si rinviene inoltre in tutta la fascia delle risorgive.
Vive per buona parte dell'anno in prossimità della superficie,
preferibilmente lungo le rive, scendendo in profondità
soltanto nel periodo della latenza invernale.
Il regime alimentare dell'alborella è piuttosto vario;
importante è la componente fitoplanctonica, anche se la
dieta vegetale viene integrata da larve di insetti, oligocheti
e crostacei.
La riproduzione avviene fra giugno ed agosto; la femmina
depone in più riprese 1500-2000 uova in acque basse, lungo
le rive; le uova, piccole e leggermente adesive, si schiudono
nel giro di una settimana. La maturità sessuale viene
raggiunta intorno al terzo - quarto anno di età.
Questa specie può ibridarsi con relativa facilità con
cavedano, triotto e scardola.
L'alborella rappresenta un importante anello nella catena
alimentare di molti ecosistemi acquatici costituendo la
principale fonte di cibo per molte specie predatrici,
come il luccio, la trota ed il persico.
Distribuzione: l’alborella nel corso dei campionamenti
con elettrostorditore è stata catturata solo a valle della
briglia di Ponte Taro; i pescatori hanno tuttavia segnalato
la sua presenza in tutto il settore di Taro ricadente
nel parco, in particolare nel tratto terminale compreso
fra Collecchiello e Ponte Taro; ritueniamo non certa questa
segnalazione, in quanto l’alborella potrebbe essere stata
confusa con altri pesci.
La sottospecie italiana era originariamente
diffusa nel bacino padano e probabilmente in Slovenia
e Dalmazia, ma in seguito è stata artificialmente introdotta
in molte altre località dell'Italia centro-meridionale.
Torna all'inizio
Carpa
Cyprinus carpio
Caratteristiche: 35-40 squame lungo la linea laterale
(nella varietà selvatica); pinna dorsale con 17-22 raggi
indivisi; pinna anale con 3-5 raggi divisi; 4 barbigli
ai lati della bocca. Lunghezza massima fino a 130 cm;
peso fino 45 Kg.
Descrizione: esistono diverse varietà di carpa,
frutto della selezione operata dagli allevatori sin dall'antichità.
Le 3 forme principali sono: la carpa regina (forma selvatica)
con il corpo completamente ricoperto da squame; la carpa
a specchi con evidenti soltanto poche grosse squame situate
sul dorso, lungo la linea laterale e sul ventre; la carpa
cuoio (forma nuda) con il corpo praticamente privo di
squame se si eccettua una piccola fila che segue il profilo
del dorso.
La forma selvatica ha un corpo abbastanza massiccio,
ma non eccessivamente tozzo, il dorso non molto arcuato,
la colorazione di fondo è bruno-olivastra con il ventre
giallastro.
Il capo è grande, quasi conico dotato di una bocca protrattile
caratterizzata da grosse labbra carnose.
Particolarmente robusti sono gli opercoli che, garantendo
una chiusura efficace, permettono alla carpa di resistere
in ambienti fangosi senza che possano entrare corpuscoli
estranei nelle branchie.
Le varie forme ottenute per selezione si distinguono
oltre che per la quantità di squame anche per la colorazione,
che può essere bruna, argentea e talvolta anche dorata;
la forma del corpo in queste varietà è, in genere, molto
più tozza.
Biologia: la carpa è un tipico abitatore di acque
lente, temperate, con abbondante vegetazione acquatica.
E’ un specie dalle abitudini gregarie, soprattutto nei
primi anni di vita. Staziona in prossimità del fondo,
dove si muove soprattutto nelle ore notturne durante le
quali ricerca, con l'ausilio dei barbigli che hanno funzione
tattile, macroinvertebrati bentonici e detriti vegetali
che costituiscono la base della sua alimentazione. La
carpa è attiva a partire dalla primavera inoltrata sino
ai primi freddi dell'autunno; quando la temperatura scende
al di sotto dei 10°C la carpa si infossa nella melma in
uno stato di latenza che dura per tutta la stagione fredda.
La riproduzione avviene quando la temperatura dell'acqua
è compresa fra i 17 ed i 20°C e cioè, nei nostri ambienti,
fra maggio e giugno. Ogni femmina depone circa 100.000
uova per Kg/peso che schiudono nel giro di una settimana;
gli avannotti hanno un accrescimento piuttosto lento ed
alla fine del primo anno di età misurano intorno ai 5-6
cm.
Distribuzione: nelle acque del Parco la presenza
della carpa è piuttosto sporadica e limitata al tratto
inferiore compreso fra Giarola e Ponte Taro.
La carpa è stata una delle prime specie
ittiche alloctone introdotte in Italia; la sua immissione
nelle nostre acque pare sia avvenuta nel I sec. d.C. ad
opera dei romani. E’ diffusa in tutta Italia.
Torna all'inizio
Carassio
Carassius auratus
Caratteristiche: 30-35 squame lungo la linea laterale;
pinna dorsale con 14-22 raggi divisi; pinna anale con
5-8 raggi divisi; 23-35 branchiospine sul primo arco branchiale.
Lunghezza massima fino a 50 cm; peso fino a 1,8 Kg.
Descrizione: il corpo è alto, arcuato nella parte
dorsale, abbastanza simile a quello della carpa. Il carassio
è un pesce estremamente polimorfo: esemplari di forma
allungata si rinvengono in acque ferme mentre nei grandi
laghi e nei fiumi si possono trovare individui assai tozzi.
La bocca è piccola, priva di barbigli, le labbra sono
poco carnose. Il corpo è ricoperto da grosse squame lucenti;
la pinna caudale ha gli apici leggermente appuntiti.
Il colore del dorso è brunastro, i fianchi ed il ventre
sono giallastri con riflessi scuri.
Biologia: il carassio rappresenta l'esempio più
tipico della dannosità che deriva dall'immissione nelle
acque interne di specie alloctone. È un pesce dotato di
eccezionali capacità di adattamento e resistenza alle
più avverse condizioni ambientali.
Sopporta livelli di inquinamento organico altissimi,
letali per la maggior parte delle altre specie ittiche
presenti nelle nostre acque;è in grado di sopportare variazioni
di temperatura comprese fra 0°C e +30°C e più e vive anche
in acque con concentrazioni di ossigeni inferiori ad 1
mg/l.
Questo insieme di prerogative gli permettere di competere
con successo con molti altri ciprinidi che condividono
la sua stessa nicchia ecologica; particolarmente penalizzata
dalla sua presenza è la carpa, con la quale il carassio
instaura una serrata competizione alimentare.
Frequenta tutte le acque lente o stagnanti, preferibilmente
ricche di vegetazione; l'alimentazione è estremamente
variata e comprende zooplancton, macrozoobenthos ed anche
elementi vegetali.
La riproduzione ha luogo da Maggio a Luglio; ogni femmina
depone su piante acquatiche da 150 a 300 mila uova che
schiudono nel giro di una settimana.
Distribuzione: il carassio è presente, anche se
non molto abbondante, nel settore di Taro compreso fra
Giarola e Ponte Taro.
Data l'estrema difficoltà nel distinguere il carassio
dorato dal congenerico carassio comune è assai difficile
stabilire l'attuale distribuzione di questa specie nel
resto dell’ Italia.
Fino ad una decina di anni fa era segnalato
con certezza solo nel bacino padano ma attualmente è presente
in tutta Italia, isole comprese, spesso in forma infestante.
Torna all'inizio
Lasca
Chondrostoma
genei
Caratteristiche: 52-57 squame lungo la linea laterale;
pinna dorsale con 7/9 raggi divisi; pinna anale con 8/11
raggi divisi; bocca estesa a tutta la larghezza del muso.
Lunghezza massima fino a 25 cm; peso fino a 350 gr.
 Descrizione:
è un pesce dal corpo assai slanciato, caratterizzato da
un muso dotato di robuste labbra cornee che delimitano
una apertura boccale decisamente infera. Descrizione:
è un pesce dal corpo assai slanciato, caratterizzato da
un muso dotato di robuste labbra cornee che delimitano
una apertura boccale decisamente infera.
È molto simile alla congenerica savetta da cui si distingue
principalmente per la taglia minore, per l'apertura boccale
e per la presenza di una evidente banda nerastra longitudinale
che attraversa i fianchi.
Il dorso è verdastro, i fianchi ed il ventre sono di
colore argentato; le pinne sono grigie con sfumature rosse
o aranciate alla base delle pettorali, ventrali e della
anale.
Biologia: la lasca frequenta acque correnti e
limpide, spingendosi abbastanza in profondità nel rhitron;
predilige i fondi ciottolosi o sabbiosi di fiumi con buona
portata, ma si rinviene talvolta anche in acqua lacustri.
È una specie abbastanza esigente per quanta riguarda
il tenore di ossigeno disciolto nelle acque.
È di indole gregaria e forma branchi numerosi soprattutto
durante il periodo della fregola.
L'alimentazione è varia: elementi vegetali che la lasca
preleva dal fondo sfruttando le labbra cornee vengono
integrati frequentemente da invertebrati acquatici.
La riproduzione ha luogo fra Aprile e Maggio, su fondali
ghiaiosi; la schiusa avviene nel giro di 10 giorni.
È una specie in fase di contrazione demografica, penalizzata
oltre che dall'inquinamento anche dagli sbarramenti fluviali
che impediscono alle lasche di raggiungere i luoghi adatti
per portare a termine con successo i processi riproduttivi.
Distribuzione: la lasca è presente omogeneamente
in tutto il settore di Taro compreso all’interno del Parco;
le popolazioni più numerose si rinvengono tuttavia nel
tratto di fiume compreso fra Fornovo e Giarola.
Questa specie è presente nei maggiori
fiumi dell'Italia settentrionale e lungo la fascia adriatica
sino a livello del fiume Tronto in Abruzzo; è segnalata
inoltre nei laghi di Viverone, Candia, Monate, Varese,
Garda ed altri minori.
Torna all'inizio
Savetta
Chondrostoma
soetta
Caratteristiche: 55-63 squame lungo la linea laterale;
pinna dorsale con 8/9 raggi divisi; pinna con 11/13 raggi
indivisi; denti faringei su 2 file; apertura boccale non
estesa a tutta la larghezza del muso.
Lunghezza massima fino a 45 cm; peso fino a 2 Kg.
Descrizione: è un pesce dal corpo abbastanza slanciato,
con il capo piccolo caratterizzato da un muso che presenta
labbra cornee sporgenti; la bocca arcuata si apre in posizione
infera.
Il colore del dorso è grigio-verdastro, i fianchi sono
chiari, con riflessi argentati, finemente punteggiati
di nero; il ventre è bianco.
Le pinne sono di colore variabile dal grigio al giallastro;
le pinne ventrali e quelle pettorali possono presentare
sfumature rossastre; i lobi della caudale sono decisamente
acuti.
Biologia: le conoscenze sulla biologia della savetta
sono piuttosto scarse e datate; è una specie che vive
prevalentemente in acque profonde di fiumi con buona portata
idrica.
Frequenta sia acque con discreta velocità di corrente
che ambienti lentici, dove forma branchi a volte numerosi
ma più spesso di pochi individui.
L'alimentazione è varia ed è composta da invertebrati
acquatici, uova di altri pesci e, soprattutto nel periodo
estivo, da materiale vegetale che viene prelevato con
l'ausilio delle grosse labbra dal margine tagliente.
La riproduzione avviene nella tarda primavera, le uova
molto numerose, vengono deposte su fondali ciottolosi
o ghiaiosi probabilmente in prossimità di macrofite sommerse.
Le uova schiudono nel giro di una settimana; la crescita
è molto lenta arrivando a 20 cm in circa 4 anni.
La maturità sessuale è raggiunta nel terzo anno di età.
È una specie fortemente minacciata dagli sbarramenti
fluviali che impediscono la risalita dei riproduttori
verso gli ambienti adatti alla frega.
Distribuzione: la presenza della savetta nelle
acque del parco non è stata confermata dalle nostre indagini;
la segnalazione della sua attuale presenza effettuata
dai pescatori sportivi appare quindi scarsamente attendibile;
con ogni probabilità la rimonta di questa specie dal Po
è ostacolata dalla presenza dei diversi sbarramenti insormontabile
presenti nel tratto terminale del fiume.
La specie originariamente distribuita
in tutto il bacino padano è attualmente in una fase di
forte contrazione demografica. Si rinviene nel Po e nei
suoi principale affluenti, Adige, Brenta, Mincio, Piave,
Tagliamento, Piave, Sile, Isonzo ed in alcuni dei principali
laghi subalpini.
Torna all'inizio
|